Non c’è tempo da perdere. Bisogna abortire, abortire, abortire. Niente indugi, niente attese, niente ritardi. Il bimbo che attende di venire alla luce dal ventre della propria madre va soppresso il più in fretta possibile. Lo sentenzia la legge italiana, la Legge 194 che il 22 maggio 1978 ha reso legale la soppressione di una vita umana innocente e indifesa, ancora nutrita e accudita nello stesso seno che l’ha generata. In Italia non è lecito abortire quando si vuole, bensì entro i 90 giorni di gravidanza. Quindi l’aborto non è procrastinabile più di tanto, va consumato prima che scada come il latte nel frigorifero.
L’aborto in Italia è legalmente una necessità talmente impellente che non lo si può rimandare nemmeno ora che tutte le attenzioni e le energie del Paese sono concentrate a debellare il coronavirus. In questo momento, tutti gli interventi medici e chirurgici non di prima necessità vengono rinviati, ma l’aborto no. Si rimanda, insomma, tutto ciò che non sia salvavita per dedicarsi tutti completamente a salvare vite e a sopprimere vite, affittando «[…] un sicario per risolvere un problema», come ha avuto occasione di dire Papa Francesco in modo perfettamente laico. Andrebbe però perfezionata la procedura: siccome al tempo del coronavirus gli ospedali sono luoghi pericolosi, dove si potrebbe entrare sani e uscire contagiati, meglio conservare la salute e uccidere asetticamente a distanza.
Proceduralisticamente lo chiedono al governo Elena Caruso e Marina Toschi di PRO-CHOICE. Rete italiana contraccezione aborto dalle pagine del Corriere della Sera, invocando l’«[…] aborto farmacologico eseguito in modalità di telemedicina», ovvero il consulto medico online per la somministrazione rapida, a distanza e “indolore” di mifepristone (RU486) e di misoprostolo, le “pillole che uccidono” che oggi, nel nostro Paese, si possono assumere solo in regime di ricovero ospedaliero di tre giorni, benché qualche Regione, contrariamente alle linee di indirizzo del ministero della Salute, accorci la pratica al ricovero in day-hospital. Precedute solo di pochi giorni dalle apripista Anna Pompili e Mirella Parachini di AMICA, l’Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto, che in una lettera al Quotidiano Sanità hanno rotto il ghiaccio chiedendo di ridurre appunto tutto sempre e solo a day-hospital, la Caruso e la Toschi scrivono lucidamente che «l’epidemia del COVID-19 ci offre un nuovo argomento per dubitare che l’ospedalizzazione dell’aborto nel nostro paese risponda all’interesse della salute della donna. Quest’ultima si trova oggi inutilmente esposta al rischio del contagio in ospedale, uno scenario che può essere evitato grazie all’aborto telemedico nelle prime nove settimane. La sicurezza dell’aborto telemedico nelle prime nove settimane è ormai attestata da ampia letteratura scientifica internazionale. Introdurre l’aborto telemedico nelle prime nove settimane in questo momento è un modo efficace di occuparsi della salute dei cittadini e degli operatori sanitari, e soprattutto di massimizzare le risorse scarse della sanità pubblica in un momento di emergenza come quello odierno».
Bisogna appunto abortire, abortire, abortire. Cascasse il mondo, l’aborto non si ferma. E così, prima che sia troppo tardi, giù la pillolina prescritta in videochat, in attesa del salto a velocità della luce quando magari avremo persino l’autodichiarazione via WhatsApp, una delle tante, del resto compilabile pure, perché no, al momento. Sono necessità, come si fa a negarle?
Scoppieremo di salute, insomma, per uccidere con tranquillità nel comodo isolamento con cui in questi giorni si cerca di salvare vite. E così, quando il coronavirus sarà finalmente solo un ricordo e torneremo liberi per l’apericena, la vita umana si sarà persa in un bicchiere d’acqua, in un aperiaborto fai-da-te.













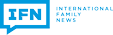





Commenti su questo articolo