Last updated on Novembre 24th, 2022 at 04:26 am
Un disastro totale. Nelle elezioni “di medio termine” con cui l’8 novembre gli Stati Uniti d’America hanno eletto per intero la Camera dei deputati e un terzo circa dei senatori che dal 3 gennaio comporranno il 118° Congresso federale, non solo non si è materializzata la cosiddetta «onda rossa», cioè la vittoria netta del Partito Repubblicano (grosso modo dal 2000 si usa in modo ubiquo il colore rosso per indicare i Repubblicani), che alla vigilia sembrava una realtà, ma la loro sconfitta è stata enorme. Sarà infatti sconfitta cocente comunque anche se i Repubblicani, finiti gli ultimi conteggi ancora in fieri, dovessero ottenere la maggioranza alla Camera. Per almeno sei ragioni.
La prima è che il Senato è perduto. Dopo le elezioni dell’8 novembre i Democratici contano 48 senatori più due “finti” indipendenti che si schierano sempre dalla loro parte. Totalizzano cioè quota 50, che è la metà dell’assise. Ora, già questa parità una vittoria Democratica e una sconfitta repubblicana, poiché, nel caso in cui la parità si presentasse in aula anche in sede di voto, al Senato sarebbe decisivo il voto del presidente di quella “Camera alta” il quale coincide con il vicepresidente federale, ossia oggi Kamala Harris, la vice di Joe Biden. Che qualche senatore Democratico rompa i ranghi in sede di voti per alterare la maggioranza è improbabile, benché non impossibile: comunque sia dannatamente arduo. Dunque, se anche i Repubblicani vincessero il seggio senatoriale non ancora assegnato in Georgia (lo sarà il 6 dicembre mediante ballottaggio), al Senato i Repubblicani hanno perso.
La seconda è che nel Senato del 118° Congresso i Repubblicani hanno già meno peso che nel 117° Congresso, pur con il seggio della Georgia ancora da assegnare, perché, rispetto, alla composizione dell’assise precedente, non solo non hanno guadagnato alcun seggio, ma ne hanno addirittura perso uno: il seggio senatoriale della Pennsylvania mantenuto ininterrottamente dai Repubblicani dal 1962, conquistato dal vicegovernatore Democratico di quello Stato, John Fetterman.
La terza ragione è che il Fetterman-ago della bilancia già adesso è un deciso alfiere dell’aborto, che ha messo come “diritto” al centro della propria proposta politica, facendone il tema principe della campagna elettorale soprattutto nelle ultime settimane precedenti il voto, mentre troppi Repubblicani sono stati, o sembrati, timidi su questo che negli annunci, avrebbe dovuto essere il tema di questa tornata elettorale.
La quarta è che, essendo il Senato decisivo per la ratifica parlamentare delle proposte di legge, il Senato a maggioranza Democratica “guidato” dal Fetterman Fetterman-ago della bilancia già adesso si getterà ora subito a pesce sulla legge che il presidente Biden e l’establishment Democratico hanno promesso di dare al Paese per sconfessare e ribaltare quanto benemeritamente fatto dalla Corte Suprema federale che il 24 giugno ha cancellato la bugia dell’aborto come “diritto”. Certo, fra i Democratici del Senato siedono sono i senatori pro-life Rober Casey Jr. e Joe Manchin, ma fra i Repubblicani persistono le filoabortiste Susan Collins e Lisa Murkovski.
La quinta ragione è che se anche i Repubblicani vincessero alla Camera, lo farebbero di stretta misura: secondo alcune proiezioni avrebbero la maggioranza con un solo di seggio in più rispetto ai 218 necessari per avere il controllo dell’Aula. Che significherebbe sì 13 seggi in più nel 118° Congresso rispetto al 117° con la conquista di 19, ma pure avendone persi 9, cosa che non era affatto prevedibile, e dunque alla fine ottenendo con un risultato tanto striminzito da essere facilmente ribaltabile al lato pratico.
La sesta è che nei cinque referendum (fra altri) sull’aborto che si sono svolti in California, Kentucky, Michigan, Montana, Oregon e Vermont in concomitanza delle elezioni «di medio termine» il diritto alla vita ha perso ovunque.
Trump ha stufato
Sì, peggio di così non poteva andare, e questo indica chiaramente due cose.
La prima è che il Partito Repubblicano deve superare subito il momento Trump. L’ex presidente Donald J. Trump è infatti oramai un ostacolo, e imbarazzante. Tutti, o quasi, i candidati Repubblicani apertamente sponsorizzati da lui nelle elezioni dell’8 novembre hanno fallito e, per timore di concorrenza, Trump ha pure criticato in maniera surreale gli unici Repubblicani che abbiano fatto elettoralmente bene. Ma, più importante ancora, la retorica di Trump non paga più e le sue proposte politiche non convincono.
Quel che Trump ha fatto alla presidenza certamente resta. Soprattutto ciò che di buono, anzi di ottimo ha fatto. Chiunque ora lo negasse sarebbe moralmente inqualificabile. Il bene che Trump ha fatto al suo Paese è sul tavolo: a partire dalla nomina dei giudici della Corte Suprema federale per continuare con le molte misure a favore della vita, della famiglia naturale, della libertà religiosa e così via. Quelle cose resteranno incise sulla pietra della storia e non scompariranno. Anzi, bisognerà ricordarle a ogni piè sospinto a fonte di una turba di orchetti mugghianti che vorranno cancellare tutto nell’indistinto di una lunga notte in cui tutte le vacche sono nere, in modo da fugare ogni dubbio.
Ma Trump ha stufato. Ricordiamo ora che il Trump improbabile delle elezioni primarie del 2016, quello che davvero non ci si augurava diventasse presidente perché ben altri e migliori vi erano in campo, lasciò il posto al Trump che ottenne la nomination presidenziale del Partito Repubblicano. Come Trump sia riuscito a farlo è cosa di cui si riempiranno ancora i libri di storia per molto, ma a quel punto si trattò di scegliere fra il grandissimo male promesso da Hillary Clinton e un male diverso, decisamente minore, molto minore, rappresentato da Trump. Ma soprattutto non era data soluzione terza. Molti, inqualificabilmente, sacrificando tutto, abbracciando l’impossibile, scelsero in quel frangente, anche in Italia, di sostenere la Clinton contro l’assurdo Trump; altri invece (fra cui chi qui scrive) optarono realisticamente per Trump.
Intanto attorno al Trump che non piaceva si radunava un mondo che, per una certa ampia parte, rappresentava qualcosa di davvero buono e così, scolandosi i toni delle guerre civili intestine, Trump è divenuto, forse malgrado sé, un simbolo e una realtà alternative al disastro Democratico. Impossibile non sostenerlo.
Quindi Trump ha vinto le elezioni e quella storia di cui egli si è trovato al centro è proseguita, non priva di momenti in cui si è veduta all’opera una “grazia di stato” che ha centrato obiettivi indimenticabili di cui non si è ancora finito di ringraziare né Trump per ciò che di suo ci ha messo (o per gli ostacoli che non ha voluto mettervi), né chi quella “grazia di stato” ha operato.
Infine Trump ha perso le elezioni del 2020 nelle urne, al contempo ha vinto fra la gente con cifre record, ma ha pure lasciato accadere quel che incrociavamo all’epoca le dita non dovesse mai accadere: la dispersione di quel popolo. Come se quella “grazia di stato” fosse venuta meno una volta lasciata la presidenza.
Ciò non significa che, dopo la presidenza Trump abbia avuto torto su tutto, ma su molto sì, e comunque non è ancora questo il punto. Il punto è che l’uragano Donald ha spazzato sia nemici sia amici. Trump non è mai stato un costruttore, nemmeno di palazzine. Ha sempre campato di rendita, cioè dell’immagine che ha saputo abilmente costruirsi. La cosa è certamente servita, e la famosa grazia di cui sopra se n’è servita bene; poi però l’arnese è tornato giocattolo e Trump un guastatore. Anzi, un guastafeste. Gli si addiceva una pensione dorata, ha rimesso invece la maglia dello sfascista.
Gli Stati Uniti continuano ad avere bisogno di chi sappia separare il grano dal loglio, raccogliendo l’eredità di Trump senza tenersi anche la pula. Qualcuno che metta fine al derby pro-Trump contro anti-Trump e guardi oltre.
L’aborto, per esempio, che adesso i Democratici faranno di tutto per blindare in una legge sanguinolenta e quello che altri, Trump compreso, hanno fatto di buono sul tema verrà vanificato.
T.S. Eliot no
La seconda cosa messa in luce della sconfitta dell’8 novembre è che, con buona pace della retorica populista sulle élite, oggi negli Stati Uniti certe élite sono meglio del popolo bue e dei suoi sciamani con le corna. I giudici della Corte Suprema federale, per esempio, sono meglio, molto meglio di molti elettori statunitensi: gli uni scelgono la sacralità della vita a fondamento della res publica, gli altri vogliono la morte. Una tristezza infinita, questa, che però non nega l’idea del padre del conservatorismo, Edmund Burke (1729-1797), secondo cui nei popoli è insita una saggezza atavica: piuttosto conferma che non sempre la coscienza autentica del popolo è la maggioranza, ovvero che la verità non è democratica.
Le elezioni dell’8 novembre hanno scattato questa fotografia dell’esistente. I Repubblicani usciti malconci dalla partita la meditino mentre archiviano la pratica Trump.
Questa seconda considerazione all’indomani del voto tollera pure un’appendice importante. I Democratici sono più furbi dei Repubblicani. Hanno un obiettivo, ideologico, e puntano verso di esso a tutta velocità. A loro non interessa l’economia, non interessa la politica estera, interessa solo lo scopo e si battono per esso. I Repubblicani dormono invece all’umido, e quindi perdono. Come questo sia, oggi, possibile, richiederebbe anch’esso libri di storia per essere accuratamente spiegato. Nell’attesa, sarebbe necessario si svegliassero.
Ciò detto, ci si domandava ieri quale sarebbe stato domani l’effetto dell’uragano Donald sul conservatorismo. La risposta sta in un pensiero vergato da T.S. Eliot (1888-1965) in For Lancelot Andrewes: Essays on style and order del 1929: «Se si considera una Causa dal punto di vista più ampio e saggio, allora non esiste una Causa persa perché non esiste una Causa vinta. Combattiamo per le cause perse giacché sappiamo che la sconfitta e lo sgomento possono essere la premessa della vittoria di chi verrà dopo di noi, benché anche quella loro vittoria sarà temporanea; noi combattiamo più per mantenere qualcosa in vita che non sperando in un qualunque trionfo».
Se una verità da questo si può trarre è che il conservatorismo dei princìpi non negoziabili non è una pepita da chiudere in cassaforte, bensì un albero di vera libertà da innaffiare, potare, concimare, accudire ogni giorno. Dimenticare di farlo anche una sola volta può costare prezzi esorbitanti.













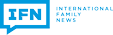





Commenti su questo articolo