Una storia da non potersi credere, quella della piccola Diana, 18 mesi, morta nella propria cameretta, dove la mamma, fuggita in vacanza con il compagno, l’aveva lasciata da sola per una settimana intera. Eppure in questi tempi si assiste, sempre più frequentemente, a episodi che, fino a poco tempo fa, parevano inimmaginabili. Casi che interrogano nel profondo le coscienze circa la presenza, nel mondo che ci circonda, del male: una presenza, per quanto invisibile, reale e attiva, percepibile da tutti, in grado di penetrare e di insediarsi nei meandri dell’animo umano, togliendo ogni capacità di discernimento, quasi impossessandosi di esso fino a renderlo esecutore freddo e lucido delle sue manifestazioni più efferate.
Non si possono liquidare casi come quello accaduto nella periferia milanese rubricandoli alla voce raptus di follia o espressione di patologie psichiatriche da cui sono affette persone deboli e provate dalla vita. Qui è doveroso interrogarsi su cosa il mondo in cui viviamo abbia perduto, da un po’ di tempo a questa parte, del sentire etico comune e su quale tipo di humus sociale, al posto di esso, si sia costruito e si stia costruendo.
Si deve, cioè, avere il coraggio e la forza di mettere in discussione i presupposti che caratterizzano il modello di vita propostoci, da almeno 60 anni a questa parte, dalla cultura oggi largamente dominante. Quella che si autodefinisce a priori progressista, non senza una certa connotazione di razzismo intellettuale, per colpire chi non intenda accodarsi agli slogan ossessivamente ripetuti dai suoi altoparlanti e si permetta di obiettare che, in realtà, il re è nudo, e pure in avanzato stato di putrefazione.
Infatti, al punto in cui si è pervenuti, non si può negare l’esistenza di un collegamento causale diretto tra, da un lato, i messaggi reiterati, in forme diverse ma equipollenti, da tutti i media ‒ «ogni desiderio è un diritto» (per esempio il “diritto al figlio”), «ognuno è padrone della propria vita» (per esempio il diritto al suicidio assistito), e così via ‒, messaggi oramai penetrati a fondo nel tessuto sociale, e, dall’altro, certi episodi inquietanti che si scatenano quando i casi della vita pongono le persone di fronte a situazioni in cui le massime della cultura dominante, di cui si è giocoforza imbevuti, si rivelano false, irrimediabilmente ritorcendosi contro qualcuno o se stessi.
Diana, una bambina di 18 mesi, indesiderata, è stata abbandonata e lasciata morire in un modo crudele. Ma, diciamocelo: c’è davvero differenza (chi ha visto sul monitor cosa avvenga durante un aborto per raschiamento o per avvelenamento può comprendere, mutatis mutandis, l’accostamento) rispetto a quanto avrebbe potuto accadere a quella piccola soltanto un paio di anni prima, quando la stessa bambina avrebbe potuto essere eliminata a norma di legge, nel più completo silenzio di tutti, ancora nel grembo della mamma? La domanda esige una risposta intellettualmente onesta.
In tutti noi non affiora mai il pensiero che, ogni volta che viene praticato un aborto volontario, si impedisce inesorabilmente a un essere umano irripetibile di proseguire quell’avventura che è la vita, quella stessa che invece a noi che abortiamo un’altra vita è stato concesso di proseguire. Se non si coglie il nesso profondo tra le due situazioni, bisogna ammettere di avere un problema grosso di sclerosi dei meccanismi mentali ed emozionali, che evidentemente funzionano a intermittenza (o, non di rado, a comando), in modo sempre più debole e con lunghi intervalli di torpore e indifferenza.













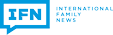





Commenti su questo articolo