Last updated on Agosto 11th, 2020 at 03:28 am
Prima si va alla clinica della morte in Svizzera, poi sarà il tribunale a vidimare il permesso per l’eutanasia, se ne individuerà le condizioni, anzi, i «nobili intenti».
Togliersi la vita è oramai un fatto privato, benché si proceda con l’assistenza di agenzie specializzate. All’occorrenza se ne occupano Marco Cappato e Mina Welby, assolti lunedì 27 luglio a Massa Carrara per il suicidio assistito di Davide Trentini, il 53enne malato da 23 anni di sclerosi multipla, che nell’aprile del 2017 ne chiese l’intervento e, attraverso il sostegno economico dell’associazione Soccorso Civile, si fece accompagnare oltre il confine italiano per porre anticipatamente fine alla propria esistenza.
Qualcosa è accaduto, insomma. Una vita sofferente è stata spezzata. Eppure il fatto non sussiste, secondo il giudice, dal quale si attendono le motivazioni della sentenza. Quel che si conosce, per ora, sono solo le richieste del pubblico ministero, Marco Mansi, il quale proponeva sì una pena di 3 anni e 4 mesi per i due imputati, ma quasi sembrava vergognarsene: «Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Sono dunque colpevoli ma meritevoli di alcune attenuanti che in coscienza non mi sento di negare». A così «nobili intenti» non possono che seguire azioni penalmente irrilevanti.
Tanto più se il comportamento «non costituisce reato ai sensi della sentenza 242/19 della Corte costituzionale», come ha osservato l’avvocato Filomena Gallo, coordinatrice del collegio difensivo di Cappato e Welby, nonché Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. Ed ecco qui, nelle parole della legale, come si riformula, ammantato di legalità, l’art. 580 del Codice Penale, che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio, e chiunque ne agevoli, in qualsiasi modo, l’esecuzione: «È stato riconosciuto che Davide Trentini possedeva quindi tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/19 della Corte Costituzionale che rende “non punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio del malato, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”».
Quale sia stato l’atto è noto. Ma quale fosse l’interesse di Davide Trentini, abbandonato alla propria autodeterminazione, non può essere definito mediante una sentenza. È stato reso pubblico il suo ultimo colloquio con i medici elvetici e, nel frattempo, anche un suo appello alla legalizzazione della marijuana. Infine, al processo, è stato ascoltato il perito di parte, il quale ha spiegato che chi si prendeva cura del corpo del morituro doveva liberarlo delle feci, poiché il paziente non era in grado di farlo da solo, e che i farmaci che egli assumeva gli facevano rischiare la vita. Rimedi e terapie non risolutivi, quindi. Ma pur sempre migliori della sua soppressione.













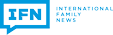





Commenti su questo articolo