Inutile negarlo, ormai irrita non appena lo si sente pronunciare. È il termine «populismo», una di quelle cose che tutti sanno di sapere, ma che nessuno sa spiegare. Forse qualcuno potrebbe sperare di essere meno banale mettendo mano alle pagine di Democrazia e populismo dello storico conservatore statunitense (ma di nascita ungherese) John A. Lukács (1924-2019) e di Populisme. Les demeurés de l’Histoire della filosofa e storica francese, pure conservatrice, Chantal Delsol, ma per lo più «populismo» è il passepartout che apre la via della fuga ogniqualvolta ci si infila in un cul-de-sac. Ovvero tutte le volte che, siccome non la si sa più guardare in faccia, si sbeffeggia la realtà per esorcizzarla come i maghi di Hogwarts fanno quando scatenano l’incantesimo Riddikulus per sconfiggere i mollicci, le creature capaci di assumere le sembianze di ciò che spaventa.
«Populista» diventa allora qualsiasi cosa sia esecrando per la mentalità dominante. Ma l’epiteto «populista» scagliato in maniera apotropaica misura semplicemente a quale punto di estraniazione sia il mondo di una certa politica, di una certa cultura e di una certa informazione rispetto alla realtà del senso comune.
Il senso comune è stato dato per spacciato forse troppo presto, lo si è creduto irrimediabilmente estinto e invece sopravvive, talora reagisce, spesso vince.
Di «senso comune» si danno due semantizzazioni, una soft e una hard. Quella soft è più o meno il «buon senso»; quella hard configura l’insieme delle certezze che ogni uomo ha e che stanno alla base di tutte le sue conoscenze successive, certezze basic che l’uomo non può negare, pena trovarsi privato della stessa capacità di conoscere. L’iniziatore della scuola di riscoperta del «senso comune» in versione hard è stato monsignor Antonio Livi (1938-2002), uno dei più importanti, anche se misconosciuti, filosofi italiani contemporanei. Il bello è che, nella pratica, nonostante le possibilità di condizionamento per opera di pre-giudizi culturali non buoni, il «buon senso» è il resto del «senso comune», di modo che nel «pre-giudizio» naturale dell’«uomo della strada» (soprav)vivano inavvertitamente gli elementi del «senso comune»: l’impronta originaria e l’imprinting che ne resta come memoria “genetica”.
Anche «pre-giudizio» tollera del resto una semantizzazione soft e una hard, la prima essendo la “concezione infondata”, la seconda il “giudizio dato prima” sulla scorta di verità immutabili e di princìpi non negoziabili (o della loro eco), come insegnano il pensatore anglo-irlandese Edmund Burke (1729-1797) e il suo “discepolo” statunitense Robert A. Nisbet (1913-1996).
Prendiamo Taiwan. È un Paese in cui la legislazione sull’adulterio e sul matrimonio, compreso il “matrimonio” omosessuale, recepisce, per lacunosamente come sempre accade nel mondo degli uomini, un sentire comune del popolo che è «buon senso» come resto del «senso comune», dunque pre-giudizio virtuoso, le cui élite politiche, però, recependo pure pre-giudizi culturali non buoni (l’«aria che tira» nel mondo) stanno cercando di manomettere quel lacunoso ma apprezzabile rapporto tra pre-giudizio popolare e legislazione naturale, venendo ostacolate, o se non altro contestate, o quantomeno rampognate, dal «senso comune» sia soft sia hard dei taiwanesi che avversano i rovesciamenti legislativi paventati per effetto di quell’impronta originaria che ha lasciato un imprinting nella loro genetica culturale e comportamentale (cioè etica).
Se il «senso comune» è ciò che mons. Livi ha riscoperto, quell’impronta non può, mai e poi mai, scomparire, per quanto combattuta e minoritaria sia. La bella notizia è però che a volte l’imprinting vivo del «buon senso» diventa maggioranza. È a questo punto che nelle élite non in più in grado di comprendere il rapporto fra impronta e imprinting scatta il meccanismo pavloviano della violenza negatrice della realtà che appiccica l’etichetta «populismo» sul sacco della spazzatura con cui cerca di mandare «buon senso» e «senso comune» in discarica. A volte però non riesce.













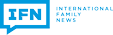





Commenti su questo articolo