Last updated on Ottobre 2nd, 2020 at 02:06 am
Il denaro ha un valore “nominale” e un valore “reale”. Essendo fondamentalmente un mezzo universale di scambio, ciò che rileva non è il suo valore “nominale” ‒ guadagno 1.000 euro al mese e l’anno scorso ne ho risparmiati 5mila ‒, ma solamente il suo “potere d’acquisto”, cioè la quantità di beni e di servizi acquisibili in un certo luogo e in un certo momento a fronte di una determinata quantità “nominale” di denaro. Se lo stipendio raddoppia ma i prezzi triplicano, l’apparente arricchimento corrisponde in realtà a un impoverimento, perché la quantità di beni acquisibili con il proprio reddito e con i propri risparmi risulta inferiore a quella iniziale.
È quindi evidente che, in presenza di rialzi generalizzati dei prezzi, il potere d’acquisto dei titolari di redditi fissi ‒ salari, stipendi, pensioni ‒ viene eroso nel tempo: i redditi tendono infatti ad adeguarsi in ritardo e solo parzialmente al rialzo dei prezzi al consumo, determinando quindi una progressiva diminuzione del potere d’acquisto. Lo stesso discorso vale ovviamente per i risparmi: in presenza di livelli di inflazione (per esempio il 2,5% annuo) superiori ai rendimenti nominali degli investimenti effettuati (per esempio lo 0,5% annuo) ‒ e quindi di rendimenti reali negativi (per restare all’esempio il 2% circa annuo) ‒, i risparmi sono destinati a “dimagrire”, cioè a perdere progressivamente potere d’acquisto. L’inflazione si può insomma considerare, a tutti gli effetti, una tassa occulta, che rende più poveri soprattutto i piccoli risparmiatori e chi vive di redditi fissi quali salari, stipendi, pensioni.
Eppure i media finanziari invocano a gran voce la ripresa dell’inflazione come la panacea, mentre tutte le principali Banche centrali del mondo inondano i circuiti finanziari di fiumi di liquidità creata dal nulla, al ritmo di migliaia di miliardi di dollari statunitensi al mese, e perseguendo con accanimento un obiettivo di inflazione annuo al di sotto ma prossimo al 2%. L’inflazione viene cioè presentata come la cura universale per uscire dalla crisi economica.
In agosto, al convegno annuale della Federal Reserve, ovvero la Banca centrale degli Stati Uniti d’America, Jerome Powell, ha addirittura proclamato l’inizio di una nuova era di politica monetaria: visto che negli anni passati l’inflazione statunitense non ha mai raggiunto il 2%, se in futuro dovesse spingersi oltre tale livello la “Fed” la lascerà correre. Il nuovo obiettivo sarà infatti un livello “medio” di inflazione del 2%. In questo modo la “Fed” potrà mantenere i tassi compressi e proseguire con gli acquisti di Treasury security, mortgage-backed security ed altre attività finanziarie (il cosiddetto quantitative easing) anche in presenza di tassi di inflazione superiori al 2%. Per i prossimi anni ci si può dunque attendere rendimenti reali negativi e non solo negli Stati Uniti, giacché probabilmente anche le Banche centrali di altri Paesi seguiranno l’esempio della “Fed”. In altre parole, la “repressione finanziaria” di rendimenti nominali artificialmente compressi deve continuare indefinitamente, anzi accentuarsi.
E perché mai? Per due ragioni: la prima, per recuperare produttività; la seconda, per sgonfiare il valore reale dei debiti.
Quanto alla prima motivazione, i salari, gli stipendi e le pensioni non si possono adeguare al ribasso, neppure in presenza di crisi profonde, per ragioni varie e ovvie. Facendo salire i prezzi e mantenendo i redditi stabili in termini nominali si ottiene indirettamente lo stesso risultato: il potere d’acquisto diminuisce come se quei redditi fossero stati sforbiciati. È una soluzione molto più facile: meno evidente, più subdola, ma sicuramente altrettanto efficace.
Quanto alla seconda e ancora più importante motivazione, essa deriva dall’enorme mole di debiti, pubblici e privati, accumulatisi negli ultimi decenni e in particolare modo dalla Grande crisi finanziaria del 2007-2009. Per rispondere alla crisi, le Banche centrali portarono i tassi verso lo zero e iniziarono politiche monetarie ultra-espansive, acquistando decine di migliaia di miliardi di dollari in titoli di debito pubblico e privato in giro per il mondo, il cosiddetto quantitative easing. La “cura” incominciò però a scoraggiare il risparmio, incoraggiare invece i consumi e i cattivi investimenti finanziati a debito, vista la liquidità abbondantissima. A livello globale, la liquidità al tempo di quella grande crisi si aggirava infatti attorno ai 40 trilioni di dollari statunitensi, ma è balzata a 80 trilioni alla fine del 2019 e oggi ha superato gli 88 trilioni. In piena pandemia da CoViD-19, la liquidità mondiale, già spropositata rispetto alle dinamiche dell’economia reale, si è quindi accresciuta di ulteriori 8 trilioni di dollari, al ritmo di centinaia di miliardi di dollari in più ogni mese. La pandemia ha insomma spinto ancora la “finanziarizzazione dell’economia”, le Borse sono tornate a volare mentre le economie sono collassate e le Banche centrali si sono confermate il vero protagonista della vita economica e finanziaria dei Paesi del mondo. Oggi risolvono i problemi che hanno creato ieri e domani si occuperanno di risolvere i problemi che stanno creando oggi, come un dentista che cura i denti cariati ma regala caramelle ai propri pazienti.
Prima del CoViD-19 i debiti mondiali si aggiravano attorno ai 250 trilioni di dollari statunitensi, ossia oltre il 100% del PIL mondiale. Come ha dichiarato Powell nel novembre 2019, «il debito sta crescendo più velocemente dell’economia. È molto semplice. Ma per definizione è insostenibile». Da allora la situazione è molto peggiorata: i debiti pubblici sono aumentati ancora per far fronte all’emergenza prima sanitaria, poi economica e quindi sociale, e adesso sono destinati a salire ulteriormente, laddove le economie mondiali sono invece in recessione profonda. Come uscire dall’impasse?
In questo contesto, infatti, i debiti risultano insostenibili: diversi sono gli Stati ‒ tra cui l’Italia ‒, ma pure moltissime grandi imprese private del mondo, che finirebbero in default se dovessero pagare interessi normali sui propri debiti. I tassi a zero hanno finora consentito di stabilizzarli, ma la cura non basta più, visto l’incancrenirsi della situazione. Ecco allora la “medicina” delle Banche centrali: mantenere la “repressione finanziaria” a oltranza (cioè rendimenti nominali schiacciati artificialmente verso e sotto lo zero) e fare ripartire l’inflazione, a ogni costo, per anni a venire. Una decina d’anni di questa “cura”, a base di rendimenti reali negativi, consentirà di diminuire il valore reale dei debiti in circolazione di oltre un quinto. Essendo un gioco a somma nulla, il conto sarà pagato dai risparmiatori che vedranno il proprio patrimonio diminuire in termini di potere d’acquisto dello stesso importo.
È la classica “uscita inflazionistica dalla crisi”, tipica dopo le guerre: una sorta di default de facto, comunque sempre ai danni dei creditori. I risparmiatori, in specie i classici BOT-people, si troveranno a sostenere una marcata perdita di potere d’acquisto negli anni a venire perché non riusciranno a proteggere i propri risparmi dall’inflazione. Inevitabilmente i risparmi saranno scoraggiati, con incentivo a consumare oltre che a investire in modo azzardato, sia sui mercati finanziari sia nell’economia reale. Inoltre, con il passare del tempo lo stipendio o la pensione faticheranno a stare dietro ai prezzi crescenti del carrello della spesa.
L’inflazione è sempre stata, e lo sarà ancora di più negli anni a venire, un modo per trasferire surrettiziamente, ed iniquamente, ricchezza dalla formica alla cicala, dal creditore al debitore. E se ne dovrebbe anche gioire?
Pensare che l’inflazione generi crescita economica reale e occupazione nel lungo periodo è purtroppo solo una delle tante fallacie economiche che sopravvivono, nonostante la storia economica presenti lunghi periodi di crescita economica insieme a deflazione, oppure, specularmente, periodi di forte crisi e disoccupazione accompagnati da tensioni sui prezzi. Si pensi per esempio alla “stagflazione” degli anni 1970, che dimostrò l’inconsistenza della cosiddetta «curva di Phillips» ‒ dal nome dell’economista neozelandese Alban William Phillips (1914-1975) ‒, che vorrebbe inflazione e disoccupazione inversamente correlate.
Gli squilibri finanziari forse diminuiranno, ma diventeremo tutti un po’ più poveri. In particolare ne uscirà malconcio il ceto medio, il cui nerbo sono le piccole imprese, spesso, in un Paese come il nostro a conduzione familiare, e soprattutto le famiglie, asset strategico dell’economia italiana. Siamo cioè entrati oramai nell’era del socialismo finanziario delle Banche centrali, dove si incentiva l’azzardo morale, ma poi, se le cose si mettono male, si presenta il conto ai risparmiatori e ai contribuenti, ovvero alle famiglie. E siamo soltanto agli inizi.













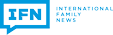





Commenti su questo articolo