Last updated on Settembre 25th, 2020 at 01:43 am
«Legge contro l’omotransfobia: al centro c’è il linguaggio», così titolava La libreria delle donne di Milano il 5 luglio – si era in Italia allora nel pieno del dibattito sul «DDL Zan» – in un pezzo in cui si affermava che «ogni mutamento che avvenga nel linguaggio ha il potere di influire sull’identità personale». D’altra parte lo precedeva di pochi giorni l’affermazione dell’editorialista de la Repubblica, Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’ISTAT, secondo cui «l’identità è una costruzione sociale in divenire, le vite non sono più prescritte in maniera rigida».
Usando il concetto di «identità di genere», la battaglia per cosiddetti “diritti” di una minoranza sta insomma diventando «un magheggio con cui scompare la realtà dei corpi», di fatto discriminando direttamente più di metà della popolazione mondiale: le donne, per l’appunto. Si tratta, d’altronde, di una questione che non riguarda solo il nostro Paese, e che neppure si sia sviluppata nelle ultime settimane, come spiega lo specialista italo-statunitense Stefano Gennarini nel notevole The Gender Agenda: How the LGBT Movement is Hijacking Women’s Rights.
Il «genere» nelle politiche delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale
Siamo agli inizi degli anni 1990, quando all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è iniziato a comparire il termine «gender» in evidente e inequivocabile riferimento alle disparità – sociali, politiche ed economiche – tra uomini e donne. La parola «genere» viene qui utilizzata per indicare i due sessi biologici – uomo e donna – al fine di promuovere l’emancipazione del cosiddetto «sesso debole» (le donne, come tocca ormai specificare), nonché l’uguaglianza tra uomo e donna.
In trent’anni le cose sono però notevolmente cambiate, e nella politica delle Nazioni Unite, così come a livello del diritto internazionale, il concetto di «genere» non ha più un riferimento indubitabile al dato biologico, ma è diventato lo strumento attraverso cui gruppi di minoranza, incapaci di ottenere sostegno politico per ritagliarsi democraticamente il proprio spazio, hanno scippato alle donne non solo le armi, ma pure il campo di battaglia.
Sia nel 1996, sia successivamente nel 2010, gli Stati membri delle Nazioni Unite – durante l’Habitat Conference di Instanbul prima e nell’ambito dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile (UN Woman) poi – hanno concordato, come afferma il Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), che «la parola “genere”, utilizzata nella Piattaforma d’azione, doveva essere interpretata e intesa secondo l’uso ordinariamente e generalmente accettato». Con affermazione decisamente più esplicita, lo Statuto di Roma del 2000 della Corte penale internazionale – che, a differenza delle conferenze delle Nazioni Unite, ha valore vincolante per il diritto internazionale – ha specificato ulteriormente: «ai fini del presente Statuto, resta inteso che il termine “genere” si riferisce ai due sessi, maschio e femmina, nel contesto della società. Il termine “genere” non indica alcun significato diverso da quanto sopra».
Qualcosa è cambiato
Sempre più spesso, allontanandosi dalle esplicite definizioni concordate, diverse agenzie delle Nazioni Unite, come in particolare l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), includono uomini che si dichiarano omosessuali o uomini che si identificano come donne nelle proprie “politiche di genere”. Si legge, infatti, nell’Integrating Gender Equality and Female Empowerment in USAID’s Program Cycle, una definizione di «violenza di genere» decisamente ambigua: «la violenza di genere è una espressione generica per indicare qualsiasi minaccia o atto dannoso diretto a un individuo o a un gruppo in ragione del sesso biologico reale o percepito, dell’identità e/o dell’espressione di genere, dell’orientamento sessuale e/o della non adesione alle diverse norme socialmente costruite sulla mascolinità e femminilità». Un cambiamento decisamente significativo, questo, visto il potere dell’USAID di coordinare le azioni delle varie agenzie internazionali e dove è ormai d’uso l’allocuzione poetica «forme multiple e intersecanti di discriminazione», onnipresente ormai nelle Risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU.
È del luglio scorso l’evento Gender Diversity Beyond Binaries in cui Phumzile Mlambo-Ngcuka, direttore esecutivo delle donne delle Nazioni Unite, ha annunciato che l’agenzia non si sarebbe più concentrata solo sui diritti delle donne, ma piuttosto sull’uguaglianza «di tutti i generi», tra cui LGBTQ+ (lesbiche, bisessuali, gay, transgender, queer, intersessuali, pansessuali, non conformi al genere, non binari e l’intera gamma delle diversità di genere oggi date per esistenti). Non è peraltro secondario sottolineare che Mlambo-Ngcuka sovrintende un budget annuale di quasi 1 miliardo di dollari statunitensi, denaro che non verrà più utilizzato esclusivamente in azioni a favore delle donne, ma che verrà re-indirizzato a uomini che variamente esercitano la propria attività genitale o che si trovino in conflitto con il genere biologico di nascita.
Il «genere» come costrutto sociale: si parla del sesso degli angeli?
Anche la Commissione per il diritto internazionale preme per modificare la definizione di genere contenuta nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, domandando una definizione di genere come «socialmente costruito», e così elevando l’orientamento sessuale e l’identità di genere a categorie protette del diritto internazionale. In questo modo ogni Paese subirebbe pressioni per riconoscere le «diverse varietà di genere» come «imperativo dei diritti umani».
Se questo dovesse accadere, ciascun individuo potrebbe descriversi inventando un genere proprio e qualsiasi ulteriore tentativo di definizione oggettiva si ridurrebbe a una discussione sul sesso degli angeli (basti pensare al numero di autodefinizioni soggettive proposte da Facebook). Ciò avrebbe inevitabilmente conseguenze sul diritto internazionale, nonostante la Commissione di diritto internazionale non abbia di per sé l’autorità di modificare autonomamente lo Statuto di Roma. Le conseguenze di questi indebiti mutamenti linguistici sono però concretissime: donne e ragazze vengono cancellate dall’assistenza internazionale e messe da parte nella programmazione.
Se avesse ragione la Sabbadini, che definendo l’identità «costrutto sociale» legittima di fatto le pretese delle comunità LGBT+ di modificare le politiche delle agenzie internazionali in proprio favore, le femministe dovrebbero dichiararsi definitivamente sconfitte. Qualsiasi individuo nato con corredo cromosomico XY, semplicemente dichiarando di “sentirsi donna” può non solo scippare privilegi ottenuti in anni e anni di battaglie femministe, ma addirittura macchiarsi di crimini contro le donne. Accade, di fatto, già nel mondo.
Sono gli esiti di un estremo nominalismo gnoseologico, magistralmente spiegato ad Alice da Humpty Dumpty: «quando io uso una parola […] quella significa ciò che voglio che significhi, né più né meno». E se Alice obietta «la questione è […] se lei può costringere le parole a significare così tante cose diverse», Humpty Dumpty magistralmente risponde: «la questione è […] chi è che comanda, ecco tutto».
Tolto qualsiasi riferimento al dato di realtà, e qualsiasi ricerca del vero, resta effettivamente solo questa domanda: “chi è che comanda? Ecco tutto…”













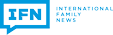





Commenti su questo articolo